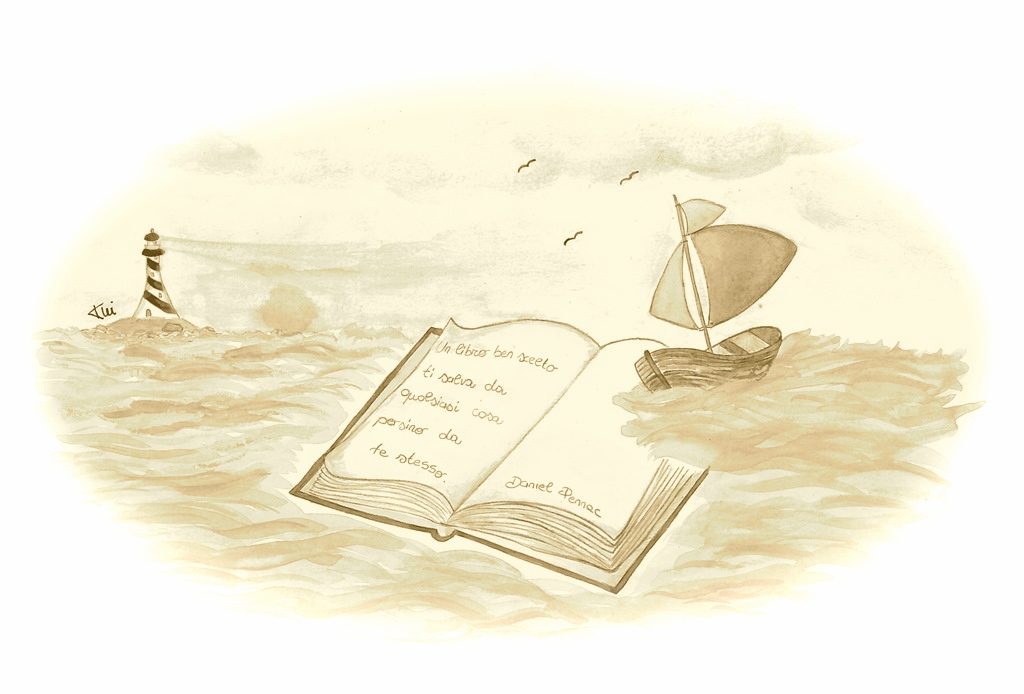
La rubrica Un libro mi disse prende spunto dal libro di Tiziano Terzani Un indovino mi disse: qui l’autore racconta di come la profezia di un indovino, da lui accolta in bilico tra gioco e cauta credulità, lo invitò a fare delle scelte che lo aprirono a nuove esperienze, permettendogli di scoprire un suo mondo tutto interiore. Ho scorto un parallelo con il fatto che spesso leggere un libro, un romanzo, un racconto, potrebbe essere l’occasione per conoscere meglio se stessi e dare una svolta non programmata alla propria vita.
Per la rubrica Un libro mi disse sono molto felice di dare voce a Giovanna Martiniello – La Darkside Coach che ci racconta quanto leggere Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez abbia contribuito alla sua scelta di studi universitari e alla rivalutazione della meraviglia!
Buona lettura!
Quando ho letto per la prima volta Cent’anni di solitudine avevo sedici anni. Ero un’adolescente scontrosa e problematica, con la passione per la lettura. Di García Márquez avevo letto solo qualche racconto, nulla che lasciasse presagire l’esperienza che avrei attraversato nel leggere il suo romanzo più famoso.
Cent’anni di solitudine è stato, per me, una lettura di una potenza sconvolgente perché ha messo in discussione le mie certezze granitiche e mi ha mostrato, per la prima volta, una realtà tridimensionale e misteriosa.
Molti anni dopo, di fronte alla scelta della facoltà, la me diciannovenne si sarebbe ricordata di quel bizzarro romanzo in cui l’autore l’aveva condotta a conoscere la magia. E scelse di iscriversi alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Se mi sono laureata in spagnolo lo devo a Cent’anni di solitudine. Ero molto indecisa sulla scelta dei miei studi universitari, non c’era nulla che mi interessasse in modo particolare ed era tempo di iscriversi. Così, la mia memoria è tornata a quel libro che aveva colorato la mia vita, fino ad allora fatta di scale di grigi. Mi sono iscritta a Lingue per leggere Cent’anni di solitudine in lingua originale. So che la motivazione può apparire illogica e poco razionale, ma se c’era una cosa che avevo imparato dal mio romanzo preferito era che la realtà ha molte sfaccettature e che non sempre la razionalità è una guida sicura.
I concetti del romanzo che si aggrovigliavano nella mia testa hanno iniziato a dipanarsi quando inserii nel piano di studi gli esami di letteratura ispano-americana e scoprii il realismo magico. Leggendo Cent’anni di solitudine, infatti, la descrizione dei luoghi e dei personaggi è assolutamente realistica. E quando García Márquez introduce l’elemento magico hai un senso di straniamento, come se l’autore avesse infranto il patto di fiducia con il lettore. Ma è solo un momento: tu, lettore, continui a credere al tuo autore, ti lasci condurre per mano, sei disposto ad affidarti. Quando Remedios, la bella, si alza in volo e sparisce in un vortice di farfalle, mi è parso di vederla: ero lì con lei e la guardavo dissolversi, carica della mia stessa meraviglia.
Ho avuto molte difficoltà a seguire il filo della trama, la prima volta che ho letto Cent’anni di solitudine. Il romanzo narra la storia di una nazione attraverso il microcosmo della città di Macondo. In questo luogo dimenticato da dio, si susseguono sette generazioni della famiglia Buendía, i cui membri hanno nomi che si ripetono. La sensazione di smarrimento e confusione aumenta con l’avanzare della lettura: da un lato l’elemento magico, dall’altra i cerchi concentrici della narrazione. Anche quando, nelle mie successive letture, mi sono munita di un albero genealogico, ho fatto fatica a ricordarmi successioni di eventi e parentele. Cent’anni di solitudine si muove in una dimensione verticale e circolare al tempo stesso, in cui a chiudere il cerchio saranno le profezie di un vecchio visionario.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo
(“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio”).
Quando il mio spagnolo è stato buono abbastanza da consentirmi di affrontare un mattone come Cent’anni di solitudine, l’ho letto davvero in lingua originale. È stata un’emozione che, a pensarci adesso, mi fa ancora vibrare. Mi sembrava di sentire quello che aveva provato il colonnello Aureliano Buendía quando suo padre, da bambino, lo portò a conoscere il ghiaccio. È quello il ricordo che gli torna in mente di fronte al plotone di esecuzione e, non a caso, è l’incipit del romanzo. Come un manifesto: questo romanzo parla di meraviglia. La sensazione di meraviglia la conosciamo tutti, perché l’abbiamo provata da bambini. È la sensazione delle prime volte: la prima volta che abbiamo visto il mare, che abbiamo accarezzato un gatto o fatto un viaggio in treno. E, in fondo, anche la città di Macondo, nata in un mondo così recente che non esistevano ancora le parole per chiamare le cose, è essa stessa manifestazione della meraviglia.
Cent’anni di solitudine è un romanzo che mi ha regalato la meraviglia, che mi ha mostrato come la magia scorre appena sotto la superficie della realtà e che, per vederla, abbiamo solo bisogno di crederci. Quando non ci riesco, quando i miei occhi non vedono che la superficie, torno a Cent’anni di solitudine, ai suoi personaggi, al real maravilloso.
Torno a credere.